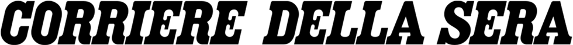Dedicato ai giovani e ai monaci della Birmania
di - Lunedì 15 Marzo 2021 ore 07:30

Alcuni anni fa ho scritto queste note.
Il Myanmar in un certo senso annuncia l’India. È miseria e desolazione nei vicoli e attorno ai fossi neri della città. Ovunque intercetti odori intensi che ti stringono la gola e ti accompagnano dentro le baracche di cartone e di latta o nelle vecchie e fatiscenti residenze coloniali dei centri storici. Non mancano anche profumi inebrianti che sembrano scioglierti dentro gli spazi immensi della foresta pluviale che sfiora e accarezza le pendici dell’Himalaya. La vecchia Rangoon sta lottando come una tigre del vicino Bengala per non smarrire la sua autenticità e impedire alla nuova Yangon di sopraffarla. I militari che tiranneggiano il paese, in preda a una concezione tardosocialista, aprono le porte alle multinazionali che elevano orribili torri di vetro e cemento sopra la splendida città coloniale.
Cammino da un quartiere all’altro e da una pagoda all’altra e cerco di non perdermi negli animati e vivaci mercati della frutta e del pesce. Provo a rispecchiarmi nelle acque sabbiose del fiume. Come una specie di camaleonte, provo ad agguantare i colori di questa città, cercando di avvicinarmi almeno un po’ alla quotidiana esistenza dei birmani. Comincio dalle cose più semplici. Per esempio chiedendo con un sorriso se posso rubare un volto con una foto o chiedere un nome.
Ho passato molte ore alla grande pagoda d’oro, imponente e accecante con il riflesso del sole. Forse uno dei templi più sacri del buddismo indocinese, certamente una tappa obbligata per tutti i birmani. Come lo è, per i tibetani, il maestoso Potala a Lhasa. E questa è la straordinaria bellezza della Birmania.
Però questo mio breve soggiorno in Birmania basta a convincermi che sessanta milioni di persone vivono in una grande prigione. Ogni giorno passo davanti alla residenza di Aung San Suu Kyi segregata nella sua casa sul lago Inya. Cerco di gettare lo sguardo al di là degli alberi, oltre i posti di guardia dei militari, e spero di vederla, di salutarla con un cenno della mano, magari di coglierlo, un saluto, per portare via con me, il suo sorriso dolce e malinconico.
Suu Kyi trascorre la sua vita imprigionata qui dal 1988, anno della sanguinosa repressione. Ma chi sono questi militari che la tengono imprigionata e allo stesso tempo soffocano la Birmania? Basterebbe rispondere: sono una sciagura per questo paese bellissimo e dolente. Ma a voler essere più precisi si tratta di un gruppo di vecchi militari autonominatosi generali.
Personaggi ombrosi e malfidati, corrotti dall’esercizio del potere e buoni a esercitarlo solo per arricchirsi e per reprimere. In ventuno – tanti sono i generali – compongono il cosiddetto Consiglio della restaurazione della legge e dell’ordine dello stato e inchiodano la Birmania in una morsa di miseria e ignoranza, negando i più elementari diritti umani e praticando la tortura più atroce nei confronti dei dissidenti.
Eppure credo che ci sia qualcosa di ancora peggiore delle carceri e dei campi per i detenuti politici, obbligati al lavoro coatto, magari per costruire quelle infrastrutture che serviranno a rendere più accogliente l’ospitalità̀ turistica. Ne sono convinto: per un popolo di profonda spiritualità come quello birmano più terribile ancora delle prigioni di mattoni e cemento devono essere le prigioni che soffocano il cuore. I generali sono arrivati anche a questo.